Vol. 2° - III.1.
ANATOMIA DELLA CELLULA EUCARIOTICA
La cellula eucariotica si compone di un protoplasma, formato da nucleo e citoplasma, e di una membrana plasmatica, che costituisce una struttura delimitante dello spessore medio di 8,5 nm e che varia a seconda del tipo di cellula.
La membrana è ricoperta dal cell
coat, il mantello cellulare, detto anche glicocalice in quanto costituito
da glicoproteine, coltre esterna morbida e flessibile dotata di spiccate
proprietà adesive e che al microscopio elettronico ha l’aspetto di lanugine
sfilacciata.
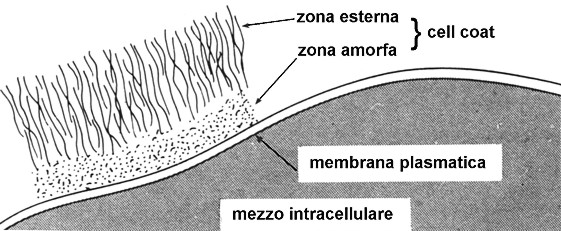
Fig. III. 2 - Membrana plasmatica e cell coat come si presentano nell’ameba
1.1. Membrana plasmatica
La membrana plasmatica è sede di numerose attività della cellula: risposta agli ormoni, interazioni cellulari, proprietà antigeniche, eccitabilità e, forse, anche espressione dei geni e della divisione cellulare.
All’inizio degli anni ’70 è stato proposto un modello della struttura della membrana plasmatica detto modello trilaminare a mosaico, valido anche per le membrane interne alla cellula, secondo il quale in un bilayer fosfolipidico sono affondate proteine che attraversano tutta la membrana da parte a parte. I principali fosfolipidi di membrana sono sostanzialmente 4: fosfatidilserina, fosfatidiletanolamina, fosfatidilcolina e sfingomielina.
Sono molecole con un’estremità idrofoba e una idrofila, quindi anfipatiche,
che quando si trovano in mezzo a due soluzioni acquose, come l’interno e l’esterno
della cellula, interagiscono tra loro disponendosi in doppio strato, strato
lipidico bimolecolare o bilayer dello spessore di circa 7-8 nm.
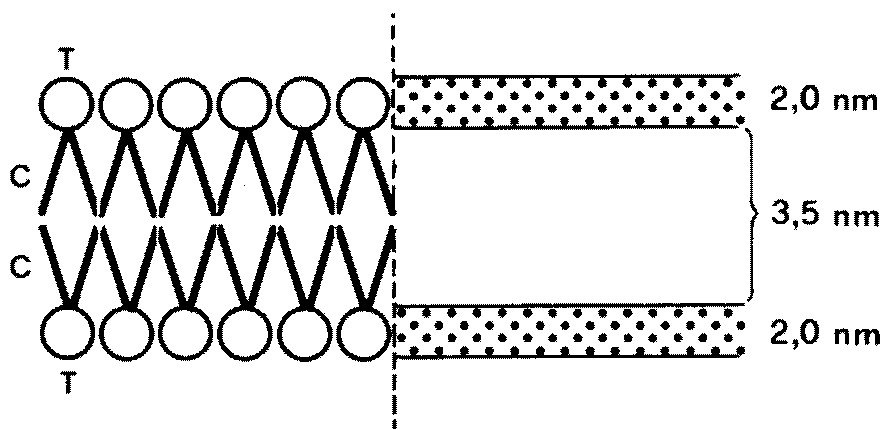
Fig. III. 3 - Membrana plasmatica in microscopia elettronica a trasmissione.
Le aree punteggiate dello spessore di circa 2 nm sono dovute alla disposizione
allineata delle teste dei fosfolipidi (T). Nello spazio chiaro interposto tra le due superfici
si giustappongono le code dei fosfolipidi (C).
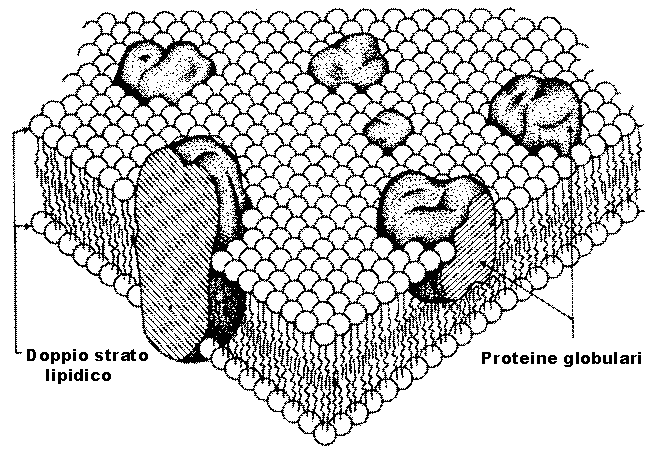
Fig.
III. 4 - Membrana plasmatica senza cell coat.
Si tratta del modello a mosaico proposto da Singer
e Nicolson.
1.2. Nucleo
Il nucleo, rotondeggiante oppure ovoidale, in seno al
nucleoplasma contiene uno o due nucleoli e zolle di cromatina.
L’involucro nucleare
è costituito da due membrane: una esterna in contatto col citoplasma e che
rappresenta la faccia citoplasmatica, una interna in rapporto con la cromatina
che vi aderisce. Uno spazio perinucleare separa le due membrane.
I pori nucleari, che si aprono attraverso l’involucro nucleare,
offrono alle sostanze esogene o endogene la possibilità di transitare sia in
direzione nucleocitoplasmatica che in direzione inversa.
La cromatina, materiale intensamente colorabile con coloranti
basici, è composta principalmente da nucleoproteine; essa si organizza in
filamenti più o meno spiralizzati, con diametro pari o inferiore a 25 nm.
Il nucleolo, con la sua matrice densa, appare come una rete di
maglie anastomizzate sulle quali spiccano componenti ribonucleoproteici
granulari e fibrillari disposti senza regola; occupa una zona variabile del
nucleo.
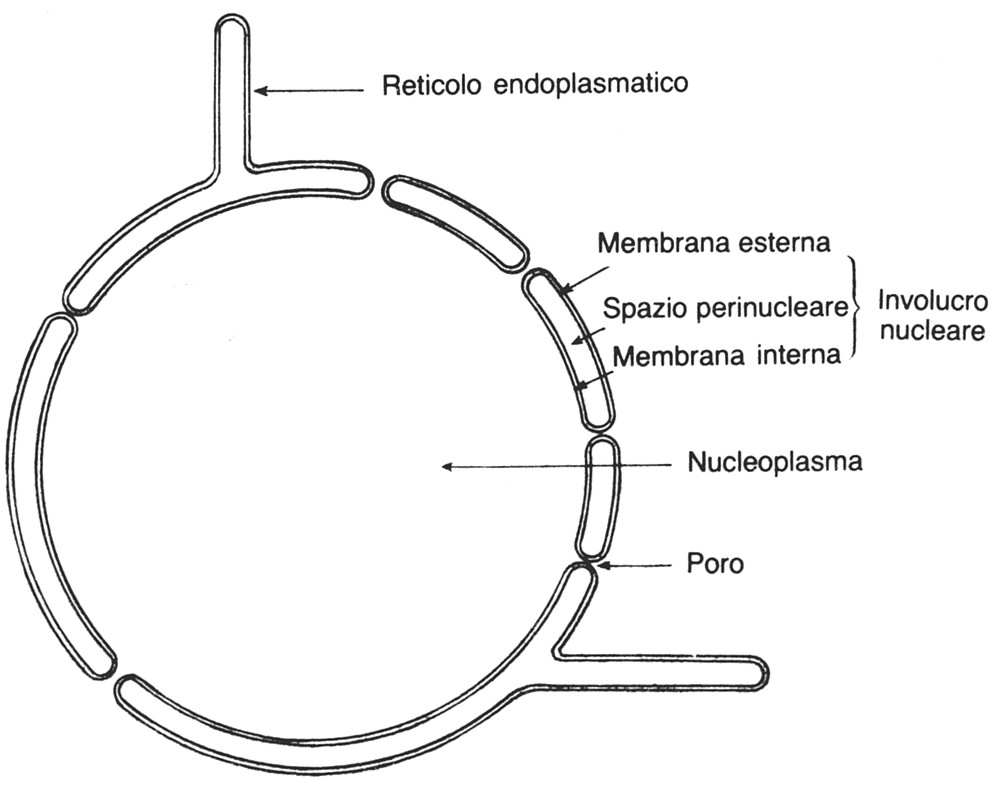
Fig. III. 5 - L’involucro nucleare
1.3. Citoplasma
Il citoplasma è costituito due
entità diverse: morfoplasma e ialoplasma.
1.3.a. Morfoplasma
Il morfoplasma comprende tutti
gli elementi figurati del citoplasma, cioè tutti i seguenti organuli
cellulari:
·
reticolo endoplasmatico granulare
- REG: è l’insieme delle cisterne appiattite le cui
membrane, sulla faccia esterna, sono dotate di granuli detti ribosomi.
·
reticolo endoplasmatico liscio
- REL: è un insieme di tubuli le cui membrane sono prive di
ribosomi.
·
mitocondri: elementi di piccole dimensioni
con diametro medio di 1mm.
Sono limitati da due membrane: una membrana esterna liscia; una membrana
interna provvista di creste che ne aumentano la superficie.
·
apparato di Golgi:
rappresenta l’insieme dei dittiosomi
della cellula. Ciascun dittiosoma comprende cisterne impilate, vescicole di
piccole dimensioni e vacuoli disposti su una delle facce del dittiosoma quando
esso è attivo.
·
lisosomi: organuli delimitati da una
membrana semplice, contenenti una sostanza omogenea, moderatamente densa, le
cui molteplici attività enzimatiche possono distruggere elementi estranei
alla cellula.
·
perossisomi: hanno diametro simile a quello
dei lisosomi e racchiudono nella loro membrana un nucleoide (formazione
paracristallina) immerso in una sostanza omogenea.
·
centrosoma: si trova in genere vicino al
nucleo. È formato da uno o due centrioli. Ciascun centriolo ha l’aspetto di un cilindro, la cui parete
leggermente opaca contiene 9 triplette di tubuli, disposte parallelamente.
·
microtubuli e microfibrille,
formanti il cosiddetto citoscheletro:
isolati o raggruppati in fasci, dispersi o localizzati, percorrono il
citoplasma. Fanno parte del citoscheletro: i microfilamenti di actina e di
miosina, i filamenti intermedi e la rete microtrabecolare.
1.3.b. Ialoplasma o Citosol
Detto anche plasma amorfo, è
una soluzione dotata di pH 7, omogenea, senza strutture, che costituisce
generalmente il 55% dell’intero volume cellulare. È quella parte del
citoplasma che non sedimenta dagli omogenati cellulari, neppure con l’ultracentrifugazione
alle velocità più elevate.
1.4. Inclusioni citoplasmatiche
Questo termine si riferisce a
strutture, granuli e materiali diversi prodotti dal metabolismo cellulare. Le
inclusioni non fanno parte del gruppo degli organuli, che sono componenti dell’apparato
cellulare preposti alla sintesi e alla degradazione. Si tratta invece il più
delle volte di sostanze
di riserva sotto forma di granuli, come il glicogeno, di vacuoli
come le inclusioni lipidiche. Le inclusioni comprendono anche i pigmenti, risultato dell’accumulo di
prodotti esogeni ed endogeni, degradati o meno, nonché i cristalloidi, formazioni proteiche
che hanno solo l’apparenza di cristalli.