Lessico
Giacomo Antonio Cortusi
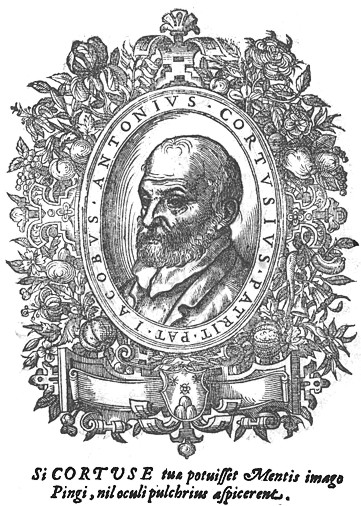
Ritratto
di Giacomo Antonio Cortusi
contenuto nell'Herbario nuovo di Castore Durante![]()
pubblicato per la prima volta a Roma nel 1585
Cortusi, Cartusi, Cortuso Giacomo Antonio nacque a Padova nel 1513 - dove morì nel 1603 - da Matteo, nobile padovano, e da Orsolina da Leon. La famiglia, per aver appoggiato Venezia nella guerra con i Carraresi, godeva di particolari privilegi, fra cui l'esenzione dalle tasse. Il padre fu letterato di una certa fama al suo tempo.
Poco si sa
della formazione e degli studi del Cortusi: laureatosi in medicina, non insegnò
subito questa disciplina, perché in lui prevaleva l'interesse per le scienze
naturali e per la botanica in particolare, studio nel quale praticamente fu
autodidatta. Nel maggio del 1573 ebbe l'incarico, da parte dell'arcidiacono di
Padova Bartolomeo di Santa Croce, vicario del vescovo, di recarsi con altri
noti personaggi in varie località del Padovano a indagare sul censo del
clero. Due anni dopo venne nominato, con G. B. Zabarella, provveditore della
Sanità a Padova, in un periodo in cui infuriava la terribile peste bubbonica![]() che
imperversò per due anni in tutto il Veneto e causò la morte di 12.000
persone a Padova e di 50.000 a Venezia. Il Cortusi dimostrò in questa
circostanza molta energia e autorità: per salvare il bestiame del Vicentino e
del Padovano egli si oppose al volere dei principi tedeschi e lo fece portare
tutto dai monti nella pianura padana. Ma il suo impegno nella lotta contro la
peste, in cui fu scarsamente aiutato dagli altri membri del Collegio medico
(alcuni, pare, si dettero alla fuga), gli fece correre anche gravi rischi:
contrasse egli stesso la peste, ma riuscì a guarire curandosi da solo; curò
poi anche una figlia e una nipote, con infusi di varie erbe: le fece
trasportare in campagna e le assistette personalmente, come continuò a fare
anche per diversi cittadini padovani.
che
imperversò per due anni in tutto il Veneto e causò la morte di 12.000
persone a Padova e di 50.000 a Venezia. Il Cortusi dimostrò in questa
circostanza molta energia e autorità: per salvare il bestiame del Vicentino e
del Padovano egli si oppose al volere dei principi tedeschi e lo fece portare
tutto dai monti nella pianura padana. Ma il suo impegno nella lotta contro la
peste, in cui fu scarsamente aiutato dagli altri membri del Collegio medico
(alcuni, pare, si dettero alla fuga), gli fece correre anche gravi rischi:
contrasse egli stesso la peste, ma riuscì a guarire curandosi da solo; curò
poi anche una figlia e una nipote, con infusi di varie erbe: le fece
trasportare in campagna e le assistette personalmente, come continuò a fare
anche per diversi cittadini padovani.
Il 10 novembre 1590 il Senato veneto designò il Cortusi a succedere a Melchiorre Guilandino nell'incarico di "ostensore dei semplici", cioè di guardiano e direttore dell'Orto botanico, fondato più di mezzo secolo prima e ritenuto il più antico del genere in Europa. Il Cortusi giungeva a quell'incarico dopo l'Anguillara, il Falloppia, il Trevisan e il Guilandino, e, nonostante le cure richieste dal suo orto privato (il cui catalogo è fra i manoscritti di Ulisse Aldrovandi), vi si dedicò totalmente. In effetti a lui si deve il notevole sviluppo che ebbe l'Orto sullo scorcio del Cinquecento; nel 1592 gli venne affiancato il botanico Giovanni Ortelio, ma il Cortusi non volle quest'aiuto e chiese che costui venisse allontanato. Continuando i lavori già iniziati dal predecessore, nel 1590 fece cintare l'Orto con un muro circolare per evitare il pericolo di inondazioni da parte del Bacchiglione; due anni dopo fece apprestare e sistemare dal fiammingo Marco Manante una tubazione di piombo per la derivazione delle acque dalla macchina già posta dal Guilandino.
Continua e
assidua fu poi la sua attività per arricchire l'Orto di nuove specie, sicché
pare che alla fine del secolo esso ne contasse più di duemila; tra l'altro il
Cortusi piantò il cedro del Libano, che dunque venne introdotto in Europa
prima del sec. XVII: il Cortusi ne parlò al Clusio![]() (Charles
de L’Écluse) in una lettera del 1568 e Pietro Pena ne riprodusse
l'illustrazione nel 1576 (p. 448). Per acquisire nuove specie all'Orto il
Cortusi compì una serie di viaggi, in Italia, in Slovenia, in Siria, nelle
isole dell'Egeo e in molte altre località; era del parere che il vegetale
dev'essere studiato nell'area di crescita e nelle condizioni ambientali volute
dalla natura, perciò ricercava i luoghi indicati dai testi antichi come
habitat delle varie piante.
(Charles
de L’Écluse) in una lettera del 1568 e Pietro Pena ne riprodusse
l'illustrazione nel 1576 (p. 448). Per acquisire nuove specie all'Orto il
Cortusi compì una serie di viaggi, in Italia, in Slovenia, in Siria, nelle
isole dell'Egeo e in molte altre località; era del parere che il vegetale
dev'essere studiato nell'area di crescita e nelle condizioni ambientali volute
dalla natura, perciò ricercava i luoghi indicati dai testi antichi come
habitat delle varie piante.
Ma oltre
ai frequenti viaggi, l'accrescimento dell'Orto fu dovuto alla corrispondenza
scientifica del Cortusi con i più importanti botanici dell'epoca, in Italia e
fuori. Oltre che amico personale, fu infatti in relazione epistolare con
l'Aldrovandi, il Clusio, il Mattioli![]() , Giovanni
e Gaspare Bauhin, Corrado Gessner, Pietro Pena, Mattia de Lobel
, Giovanni
e Gaspare Bauhin, Corrado Gessner, Pietro Pena, Mattia de Lobel![]() , Ramberto
Dodoens
, Ramberto
Dodoens![]() , Giovanni
Brancion e molti altri. Ad essi comunicava le scoperte fatte e inviava piante
rare, ed essi a loro volta gli inviavano semi, piante, disegni, fossili ecc.
Si sa ad esempio che il Gessner ricevette da lui diverse piante, tra cui la
Hiericunthida; piante esotiche e rare ricevette l'Aldrovandi, con cui il
Cortusi fu amico anche dopo il 1569, anno a cui si ferma il carteggio
pubblicato dal De Toni (sono lettere ricche di notizie sulle piante stesse,
sulle loro origini, sul modo di coltivarle, con molte indicazioni di libri
botanici, raccomandazioni di amici, cenni ai viaggi di studio oltre a problemi
personali o vicende biografiche); e il Clusio afferma nel 1580 d'aver ricevuto
dal Cortusi molte piante, tra cui la Cortusa
, Giovanni
Brancion e molti altri. Ad essi comunicava le scoperte fatte e inviava piante
rare, ed essi a loro volta gli inviavano semi, piante, disegni, fossili ecc.
Si sa ad esempio che il Gessner ricevette da lui diverse piante, tra cui la
Hiericunthida; piante esotiche e rare ricevette l'Aldrovandi, con cui il
Cortusi fu amico anche dopo il 1569, anno a cui si ferma il carteggio
pubblicato dal De Toni (sono lettere ricche di notizie sulle piante stesse,
sulle loro origini, sul modo di coltivarle, con molte indicazioni di libri
botanici, raccomandazioni di amici, cenni ai viaggi di studio oltre a problemi
personali o vicende biografiche); e il Clusio afferma nel 1580 d'aver ricevuto
dal Cortusi molte piante, tra cui la Cortusa![]() secca, e
d'aver potuto verificarne le differenze rispetto alla Sanicula
alpina, con cui egli stesso l'aveva confusa; nel 1592 afferma d'aver
ricevuto un'altra pianta, a cui il Cortusi aveva dato il nome di Myriophyllon
Pelagium (la corrispondenza tra i due botanici è testimoniata dal 1566 al
1593).
secca, e
d'aver potuto verificarne le differenze rispetto alla Sanicula
alpina, con cui egli stesso l'aveva confusa; nel 1592 afferma d'aver
ricevuto un'altra pianta, a cui il Cortusi aveva dato il nome di Myriophyllon
Pelagium (la corrispondenza tra i due botanici è testimoniata dal 1566 al
1593).

Cortusa matthioli
Oltre ai
suddetti, l'altro corrispondente col quale gli scambi di materiale di studio
furono più intensi fu il Mattioli, che in segno di omaggio diede il nome del
Cortusi a una rara primulacea, fino ad allora ignota, dal fiore rosso o
violaceo e dalle proprietà analgesiche e curative, soprattutto in caso di
ferite. Il Mattioli volle chiamarla Cortusa
(è la Cortusa Matthioli di Linneo, Auricula
Ursi laciniata seu Cortusa Matthioli
di Tournefort), dando per la prima volta a una pianta il nome di un
botanico. Il Cortusi l'aveva raccolta in Valstagna e ne aveva descritto le
caratteristiche, riprese anche nei versi di Castore Durante nel suo Herbario
nuovo, Roma 1585, che pubblica il ritratto del Cortusi e lo dice
scopritore anche di altre piante, come il Doronico. Nel 1596 gli venne
confermato l'incarico di "ostensore dei semplici" da parte dei
riformatori dello Studio, mentre l'insegnamento dei semplici all'università,
ch'egli aveva tenuto per alcuni anni (in verità, pare, senza eccessivo
seguito) già da due anni era stato affidato a Prospero Alpino![]() , il quale
fu suo successore anche come direttore dell'Orto, dopo la sua morte avvenuta a
Padova il 10 o il 21 giugno 1603 (non nel 1593 come afferma qualche biografo),
probabilmente per un attacco di apoplessia. Fu sepolto nella chiesa di San
Francesco senza alcuna lapide.
, il quale
fu suo successore anche come direttore dell'Orto, dopo la sua morte avvenuta a
Padova il 10 o il 21 giugno 1603 (non nel 1593 come afferma qualche biografo),
probabilmente per un attacco di apoplessia. Fu sepolto nella chiesa di San
Francesco senza alcuna lapide.
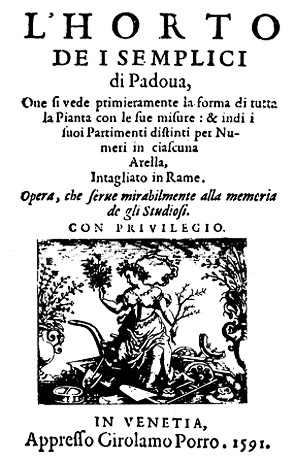
Al di
fuori della stretta cerchia dei botanici, il Cortusi non ebbe al tempo suo una
vasta notorietà, anche perché non diede alle stampe opere di rilievo, fuorché
L'horto de i semplici di Padova,
ove si vede la forma di tutta la pianta con le sue misure e indi i suoi
partimenti, Venezia 1591, Francofurti 1608 (a cura di Johann Georg Schenk, col
titolo Hortus Patavinus), che
descrive 1168 vegetali e reca anche cinque tavole, e un poco noto commento a
Dioscoride![]() dedicato
al Mattioli: I discorsi nei sei libri
della materia medicinale di Pedacio Dioscoride Anazarbeo, Vinetia 1568,
in cui raffigura per la prima volta la Cortusa.
dedicato
al Mattioli: I discorsi nei sei libri
della materia medicinale di Pedacio Dioscoride Anazarbeo, Vinetia 1568,
in cui raffigura per la prima volta la Cortusa.
Il suo merito maggiore resta legato, oltre alle specie vegetali da lui per primo descritte e analizzate (la Cortusa, il Doronico, il Satyrion Erythronium, l'Helianthus annuus ecc.), alle fortune dell'Orto botanico patavino e al suo impegno - testimoniato dalle lettere - per la diffusione di simili istituzioni anche presso altre città: in effetti l'Orto di Padova fu il modello di quelli sorti in seguito a Roma, a Ferrara e altrove.
Giacomo Antonio Cortusi auch Giacomo Antonio Cortuso oder Jacobus Antonius Cortusus (* 1513 in Padua; † 21. Juni 1603 in Padua) war ein italienischer Botaniker. Mit einer Verordnung des Dogen Pasquale Cicogna vom 10. November 1590 wurde Giacomo Antonio Cortusi zum Leiter des 1545 gegründeten Botanischen Gartens in Padua, dem ältesten Botanischen Garten der Welt, ernannt. Er tritt damit die Nachfolge des verstorbenen Melchior Wieland (Guilandinus) an. Ein Porträt von ihm befindet sich in Castore Durantes Herbario novo von 1585. Charles Plumier benannte ihm zu Ehren eine Gattung Cortusa. Carl von Linné übernahm später diese Gattung nicht, sondern stellte sie zur Gattung Thalia der Pflanzenfamilie der Pfeilwurzgewächse (Marantaceae). Linné benannte nach ihm die Gattung Cortusa der Pflanzenfamilie der Primelgewächse (Primulaceae). Möglicherweise ist auch Pietro Andrea Mattioli Urheber dieses Namens. Werke: L'horto de i semplici di Padova (Venedig, 1591).

La
Cortusa di Mattioli (nome scientifico Cortusa
matthioli, L., 1753) è un delicato e raro fiore delle zone alpine
appartenente alla famiglia delle Primulaceae.
Essendo questa specie unica
per il suo genere in Italia, difficilmente si possono trovare altre specie
simili. Il nome del genere (Cortusa)
fu introdotto dal Mattioli in ricordo del professore Giacomo Antonio Cortusi,
custode dell'Orto Botanico di Padova, morto nel 1603. Il nome specifico (matthioli)
ricorda invece Pierandrea Mattioli (Siena 1500 - Trento 1577). Il binomio
scientifico di questa specie fu definitivamente fissato da Carl von Linné![]() (1707-1778), considerato il
padre della moderna classificazione scientifica degli organismi viventi. I
tedeschi chiamano questa pianta Alpen-Glöckel oppure Heilglöckchen, mentre i
francesi la chiamano Cortuse de Matthiole e gli inglesi la chiamano: Bear's-ear
Sanicle ma anche Cortusan primrose.
(1707-1778), considerato il
padre della moderna classificazione scientifica degli organismi viventi. I
tedeschi chiamano questa pianta Alpen-Glöckel oppure Heilglöckchen, mentre i
francesi la chiamano Cortuse de Matthiole e gli inglesi la chiamano: Bear's-ear
Sanicle ma anche Cortusan primrose.
È una pianta di altezza media tra i 20 e 40 cm, con forma biologica del tipo emicriptofita scaposa (H scap), ossia piante erbacee perenni con gemme svernanti a livello del suolo e protette dalla lettiera o dalla neve, dotate di un asse fiorale eretto e privo di foglie. L'infiorescenza consiste in un'ombrella con diversi fiori (5 – 15) unilaterali dotati di pedicelli, finemente pubescenti, di varia lunghezza e arcuati alla fioritura. I fiori sono ermafroditi, attinomorfi, tetraciclici (ha i 4 verticilli fondamentali delle Angiosperme: calice – corolla – androceo – gineceo), pentameri (calice e corolla divisi in 5 parti). I fiori sono lunghi da 7 a 12 mm.
In Italia questa specie è diffusa (ma è considerata molto rara) soprattutto sulle Alpi Venete, Trentine e Piemontesi. Fuori dall'Italia è presente nei paesi dell'Europa centro-orientale, in Russia, ma anche sulla catena dell'Himalaya e in generale nell'Asia settentrionale. In effetti l'areale alpino può essere considerato l'estrema zona occidentale della distribuzione di questa specie centrata soprattutto nell'Asia (dagli Urali al Giappone). Secondo il botanico Sandro Pignatti la particolare distribuzione di questa specie sulle nostre Alpi indicherebbe che si tratta di un relitto della flora tardo-terziaria: infatti le zone in cui si trova sono aree marginali (di rifugio) fuori dai limiti della glaciazione quaternaria.
L'unico impiego di questa pianta è nel giardinaggio. Anzi, per la sua delicata bellezza viene considerata una delle più belle piante per il giardino alpino. Per una buona riuscita del suo impianto si deve sistemarla in una posizione ombreggiata e fresca, come anche si trova nella versione spontanea, in un composto terroso ricco di humus. Questa specie è considerata a rischio di estinzione quindi normalmente è protetta e ne è vietata la raccolta.