|
|
218 |
|
Ulisse Aldrovandi
Ornithologiae tomus alter - 1600
Liber
Decimusquartus
qui
est
de Pulveratricibus Domesticis
Libro
XIV
che tratta
delle domestiche amanti della polvere
trascrizione di Fernando Civardi - traduzione di Elio Corti - revisione di Roberto Ricciardi
Si raccomanda l'opzione visualizza -> carattere -> medio del navigatore
|
Octava
rursus die oculi maiores adhuc
videbantur, utpote ciceris ferme magnitudine. Totum corpus tunc sese
velociter movebat, et iam crura, et alae distincte cerni incipiebant.
Rostrum tamen interim muccosum adhuc erat. Sed forte quispiam quaerat,
cur prius superiores, quam inferiores partes in eiusmodi formatione
appareant: cui responsum velim, virtutem, seu facultatem formatricem in
superioribus magis quam in inferioribus vigere, quod spiritales sint, et
per consequens plus caloris obtineant. Caeterum istaec omnia, quae hac
die videbam, sequenti manifestiora apparebant. |
-
Embrione di pollo |
|
Decima
die non amplius caput toto
corpore maius erat, magnum tamen, ut in infantibus etiam videmus:
magnitudinis autem causa est humidissima cerebri constitutio. Quod vero
Aristoteles dicit[1]
oculos fabis maiores esse, id
profecto minime verum est, si de vulgaribus nostris fabis locutus fuerit,
cum alioqui ervi, vel ciceris albi magnitudinem non excederent: atque
hinc etiam non absurde quispiam colligat fabas antiquorum fuisse
rotundas, quales araci sunt, quem ideo fabam veterum quidam existimant.
Neque etiam verum est quod tradit[2],
{tunc}, <tunc>, scilicet,
oculos pupillis adhuc carere. Etenim hae non tantum hac die
apparebant, sed duabus etiam praecedentibus, una cum omnibus partibus,
ac humoribus. Quod vero ait detracta
cute nihil solidi videri, sed humorem tantum candidum, rigidum, et
refulgentem ad lucem, nec quicquam aliud, id de crystallino humore
mihi dixisse videtur, qui tamen haud solus apparebat, sed vitreus quoque
et albugineus, unde non parum hallucinatus videri potest Philosophus,
uti etiam Albertus, qui eo tempore nihil duri, et glandulosi in iis
reperiri existimat, cum crystallinus humor solidus sit, ac quam maxime
conspicuus. |
Al
decimo giorno la testa non si presentava più di dimensioni maggiori
rispetto al resto del corpo, tuttavia era grande, come possiamo vedere
anche nei neonati: causa della sua grandezza è la costituzione
estremamente umida del cervello. Ciò che afferma Aristotele |
|
Eadem
item die vidi omnia viscera,
nempe cor, iecur, pulmonem. Cor autem, et iecur erant albicantis coloris:
et cordis motus non solum apparebat, antequam foetum aperirem, sed iam
secto etiam thorace moveri videbatur. Erat autem pullus involutus
quartae illi membranae plurimis venis refertae[3],
ne in humore iaceret. Cernebam etiam vasa umbilicalia prope anum ad
umbilicum deferri, ibique infer<r>i, ut cibum per illum petat
foetus. Vidi denique, quod Aristoteles non advertit, in dorso prope
uropygium pennarum principia nigricantia menti humani cuti non absimilia,
cui pili abrasi sint. |
Sempre
nello stesso giorno vidi tutti i visceri, e precisamente cuore, fegato,
polmone. Cuore e fegato erano di colore bianchiccio: e il movimento del
cuore non solo era evidente prima che aprissi il feto, ma lo si vedeva
muoversi non appena era stato sezionato anche il torace. Il pulcino era
avvolto in quella quarta membrana – amnios - costellata da
numerosissime vene, affinché non giacesse nel liquido. Distinguevo
anche i vasi ombelicali in prossimità dell’ano dirigersi verso
l’ombelico, e qui penetrarvi, in modo che il feto per suo tramite si
procuri il nutrimento. Cosa che Aristotele non segnala, vidi infine sul
dorso in prossimità dell’uropigio |
|
Die
subsequenti haec omnia erant
manifestiora, et in superioris rostelli extremitate erat quid albidi,
cartilagineum, et subduriusculum, quod rursus die decimatertia magis
erat conspicuum. Erat autem rotundum milii grano haud absimile.
Sagacissima rerum parens natura id ibi fabricasse videtur, ut impediat,
ne rostello suo vel venulas, vel membranulas, vel alias quascunque
tenerrimas particulas pertundat. Aiunt mulierculae, pullos iam natos
cibum capere non posse nisi prius id auferatur. |
Il
giorno seguente tutte queste strutture erano più manifeste e
all’estremità del beccuccio superiore c’era qualcosa di
bianchiccio, cartilagineo e abbastanza consistente che poi, al 13°
giorno, era più evidente – il diamante |
|
Decimaquarta
die pullus iam totus plumescebat. Decimaquinta in digitis
ungues albicantes apparebant. Die vero decimasexta ovum aperire placuit
in opposita parte, ubi nativa tunica, sed unica tantummodo apparebat,
eaque alba. Alteram enim quam in altera parte semper videram, hic
observare minime datum est. Itaque dubitabam an ea tantum pro albuminis
tutela nata sit, cum scilicet ovum non sit recens, vel ad pulli
defensionem in ovo incubato. Nam indies illa magis magisque
decidere videtur, et foetum sequi, qui sui gravitate deorsum decidit. |
Il
quattordicesimo giorno il pulcino era già tutto impiumato. Il
quindicesimo giorno alle dita erano visibili le unghie bianchicce. Il
sedicesimo giorno ho voluto aprire l’uovo dalla parte opposta dove era
visibile la tunica appartenente al guscio, ma ce n’era una sola, e
anch’essa bianca. Infatti quell’altra che avevo sempre visto dal
lato opposto, in questo punto non è assolutamente possibile osservarla.
Pertanto ero in dubbio se essa si sia formata solamente per proteggere
l’albume quando l’uovo non è recente oppure se doveva difendere il
pulcino nell’uovo in incubazione. Infatti col passare dei giorni
sembra vieppiù abbassarsi e seguire il feto, che cade giù per il suo
stesso peso. |
|
Aristoteles
etiam unicam tantum esse eiusmodi tunicam his verbis[4]
videtur innuere. Sunt,
inquit, quandoque locata ova hoc ordine, prima, postremaque ad testam ovi
membrana posita est, non testa ipsius nativa, sed altera illi subiecta:
liquor in ea candidus est, quasi diceret, omnes partes in ovo
locatae sunt hoc ordine; nempe prima, postremaque ad testam ovi membrana
posita est. Intelligit meo iudicio per primam, et postremam membranam,
eas membra<na>s recens in incubato ovo genitas, eas videlicet,
quas aliquoties appellavi tertiam secundinam, et quartam, quam
involventem foetum dixi. Nam cum dicit testae nativam non esse, ostendit
nec primam, nec secundam esse, quae ab altera ovi parte reperitur.
Videtur igitur excludere hanc nativam sive primam, vel secundam, et
intelligere tertiam, quam secundinam saepe vocavi. Cum vero dicit[5],
sed altera illi subiecta, intelligit
eandem, secundinam nempe testae subiectam, quod vel ex hoc maxime liquet,
quod candidum in ea liquorem inesse dicat. Is enim, ut supra ostendi,
inter tertiam, et quartam continetur. Hinc manifesto errore Suessanus
convincitur, qui ex Ephesio per primam interpretatur eam, quae testae
adhaeret, per postremam vero, quae albumini. |
Anche
Aristotele con le seguenti parole sembra voler indicare che tale tunica
è solo una. Egli dice Poiché le uova sono organizzate in questo
ordine, addossate al guscio dell’uovo si trovano una prima e una
seconda membrana che non è quella appartenente al guscio, ma l’altra
che è sottostante alla prima: in essa si trova del liquido bianco come
la neve, come se dicesse che nell’uovo tutte le parti sono
disposte in questo ordine; e precisamente che la prima e la seconda
membrana sono addossate al guscio dell’uovo. A mio avviso egli intende
per prima e seconda membrana quelle membrane che da poco si sono
generate nell’uovo in incubazione, senza dubbio quelle che qualche
volta ho denominato come terza del secondamento - allantoide, e come
quarta che ho detto avvolgere il feto - amnios. Infatti, quando dice che
non è appartenente al guscio, dimostra che non è né la prima, né la
seconda che si rinviene dall’altro lato dell’uovo. Pertanto sembra
escludere che questa che appartiene al guscio sia o la prima o la
seconda, e intenda dire che è la terza, che spesso ho denominato del
secondamento. Infatti quando dice, ma quell’altra che è a essa
sottostante, intende dire quella stessa membrana, cioè del
secondamento, che si trova addossata al guscio, e ciò è estremamente
chiaro anche dal fatto che egli dice che al suo interno si trova del
liquido bianco come la neve. Infatti questo liquido, come dianzi ho
dimostrato, è contenuto fra la terza e la quarta. Quindi il Suessano -
Agostino Nifo |
|
Quae
omnia a nobis observata quotidie in sequentibus
diebus evidentiora, utpote in perfectissimo pullo apparebant. Die vero
vigesima pullus putamine a parente Gallina ablato hora vigesimasecunda
sua sponte exivit. Sequens icon ostendit situm perfecti iam pulli in
utero [ovo?[6]]. |
Tutto
quello che quotidianamente avevamo osservato si fece più evidente nei
giorni successivi, in quanto si manifestavano in un pulcino
completamente finito. Al ventesimo giorno il pulcino, asportato il
guscio a opera della chioccia, uscì da solo alla ventiduesima ora.
L’illustrazione che segue mostra la posizione in utero di un pulcino
ormai ultimato. |
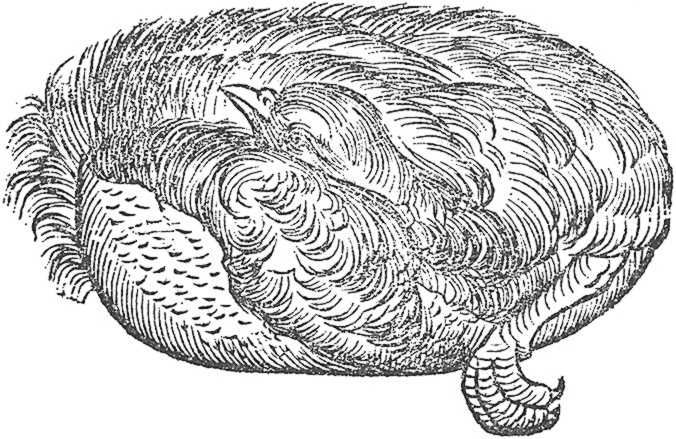
[1] Historia animalium VI,3, 561a 30-32: In questo periodo gli occhi sono prominenti, più grandi di una fava e neri; se si asporta la pelle, vi si trova all’interno un liquido bianco e freddo, assai risplendente in piena luce, ma nulla di solido. (traduzione di Mario Vegetti)
[2] Historia animalium VI,3, 561a 28: Esso ha ancora la testa più grande del resto del corpo, e gli occhi più grandi della testa; e tuttora privi della vista. (traduzione di Mario Vegetti)
[3] Stavolta è Aldrovandi che verosimilmente prende un abbaglio in questo farraginoso sovrapporsi di membrane senza un nome specifico. Questa quarta membrana dovrebbe corrispondere all’amnios che, al contrario dell’allantoide, non è vascolarizzato, e dovrebbe corrispondere a quanto riferito da Aldrovandi a pagina 216 quando riporta la descrizione tratta da Aristotele. Infatti a pagina 216 leggiamo: Tum vero membrana alia circa ipsum foetum, ut dictum est, ducitur arcens humorem: sub qua vitellus alia obvolutus membrana, in quem umbelicus [umbilicus] a corde, ac vena maiore oriens pertinet, atque ita efficitur, ne foetus alterutro humore attingatur.
[4] Historia animalium VI,3, 561b 15-18: Ogni parte si trova così disposta nel modo seguente: in primo luogo, all’estrema periferia presso il guscio c’è la membrana dell’uovo, non quella del guscio ma quella al di sotto di essa. In questa è contenuto un fluido bianco, poi il pulcino, e attorno a esso una membrana che lo isola, affinché non sia immerso nel fluido; sotto il pulcino è sito il giallo, a cui porta una delle vene menzionate, mentre l’altra va al bianco circostante. (traduzione di Mario Vegetti)
[5] Historia animalium VI,3, 561b 17: Ogni parte si trova così disposta nel modo seguente: in primo luogo, all’estrema periferia presso il guscio c’è la membrana dell’uovo, non quella del guscio ma quella al di sotto di essa. (traduzione di Mario Vegetti)
[6] Forse non si tratta di una svista di Aldrovandi, bensì di una conseguenza delle elucubrazioni di Aristotele contenute in De generatione animalium e riportate da Aldrovandi a pagina 215, per cui negli ovipari l’uovo corrisponderebbe a un utero materno staccato dalla madre.